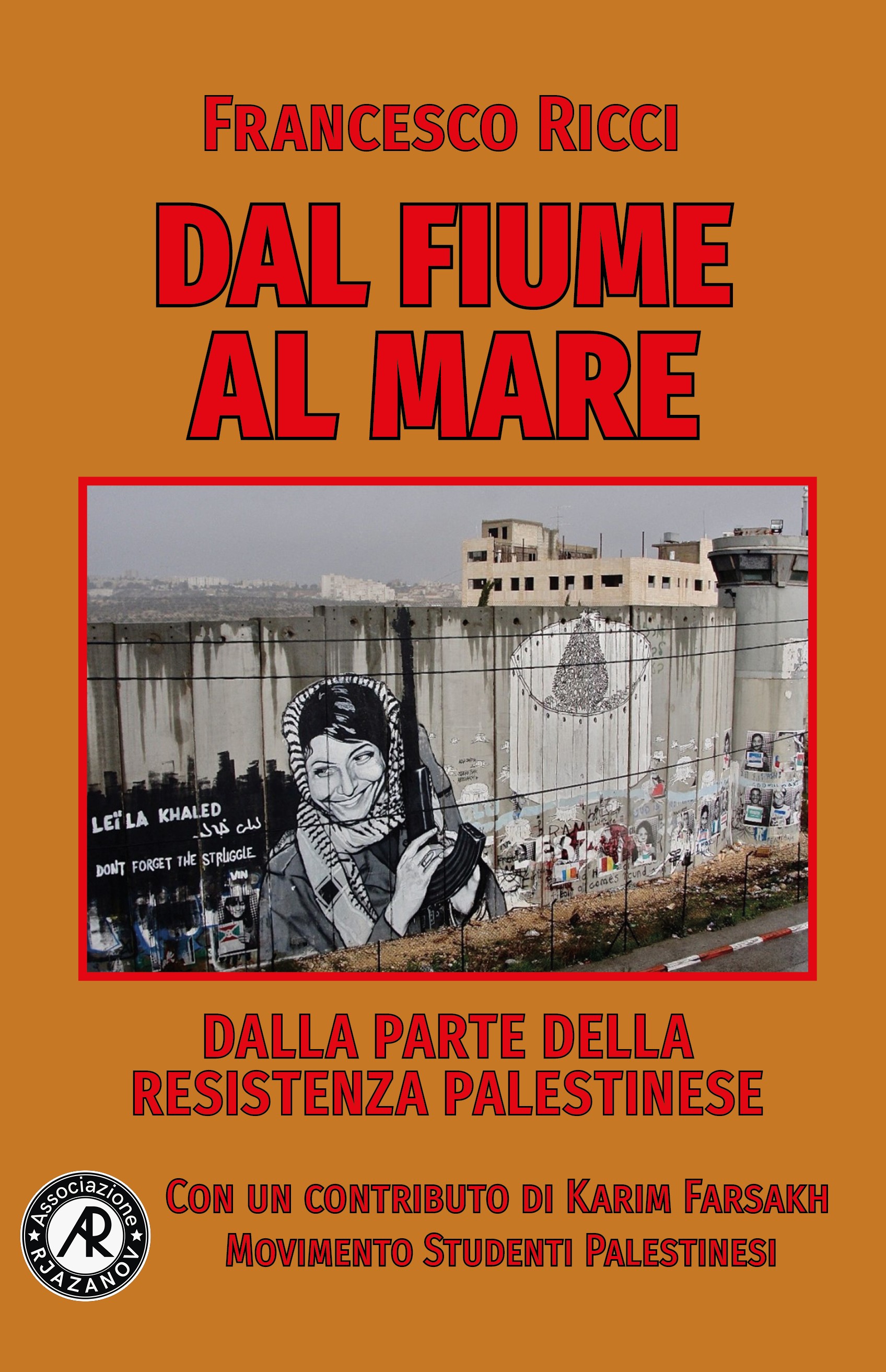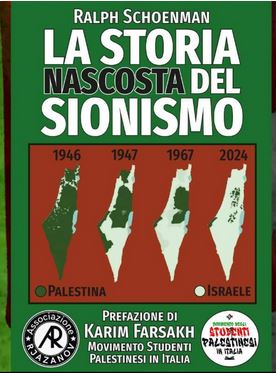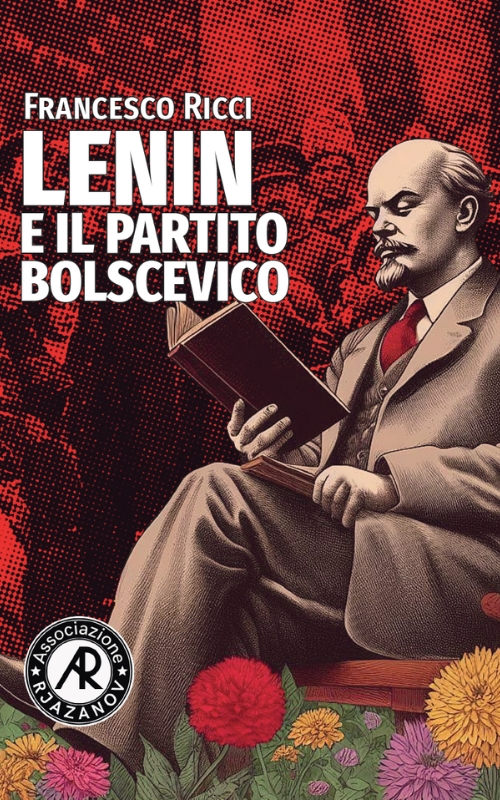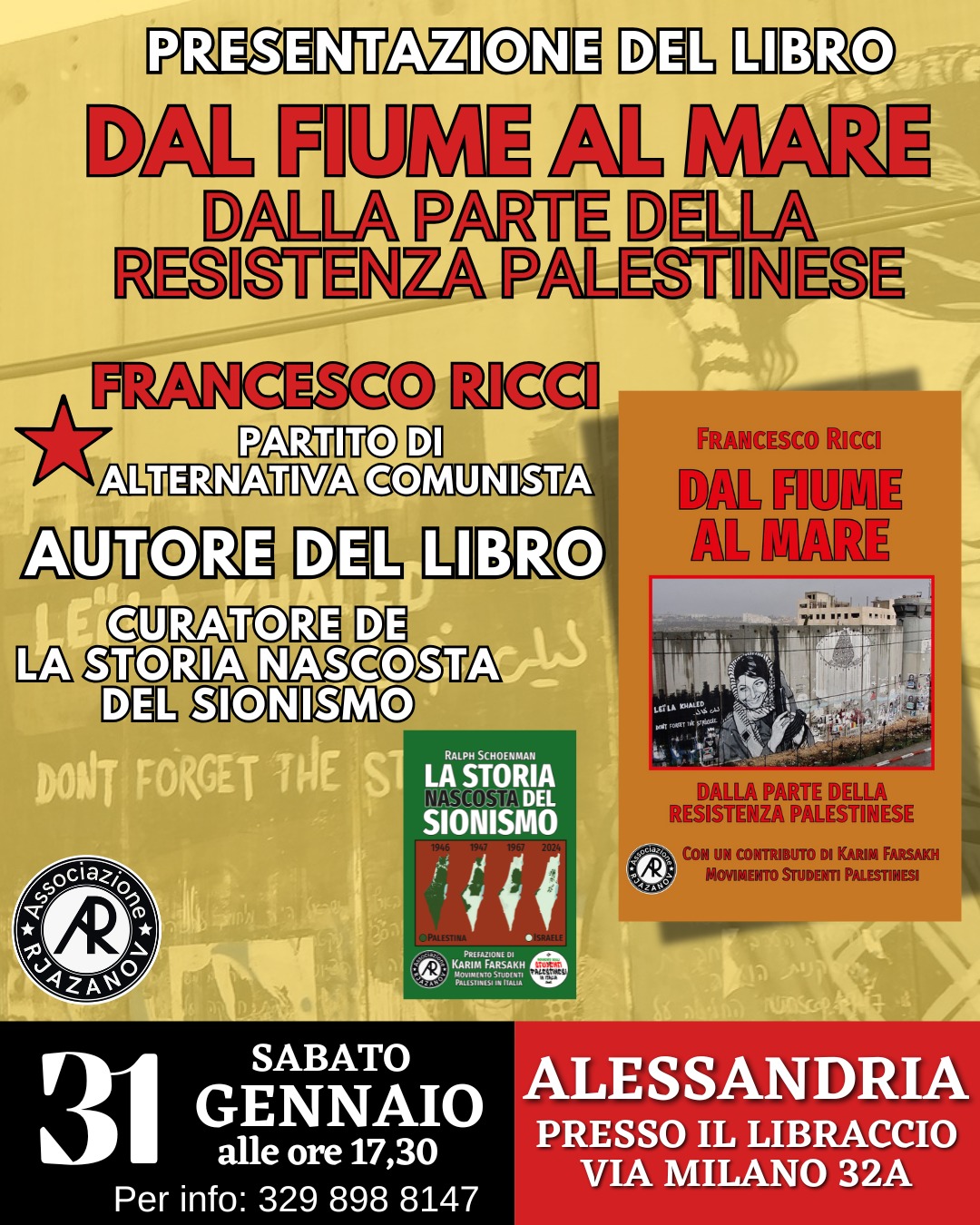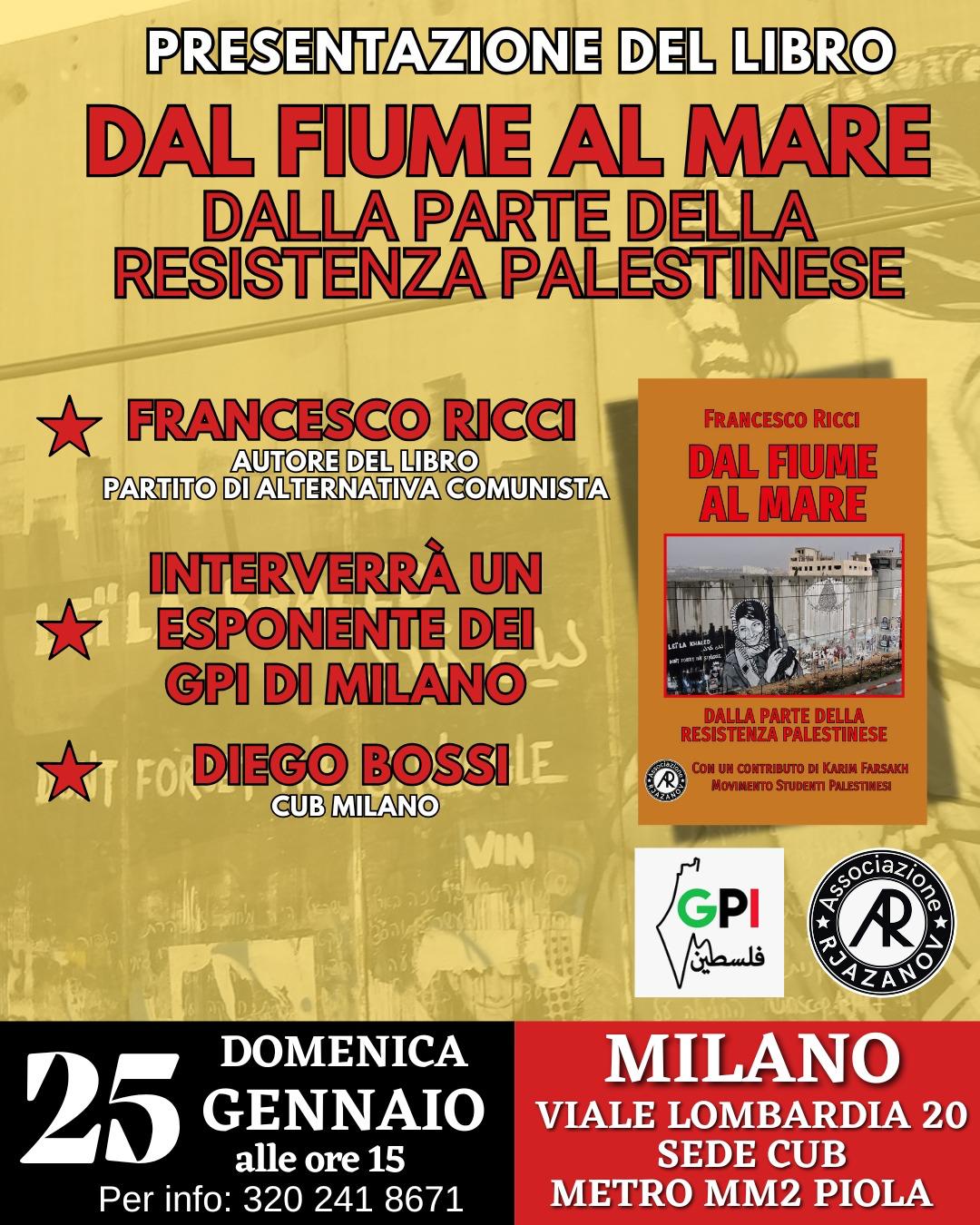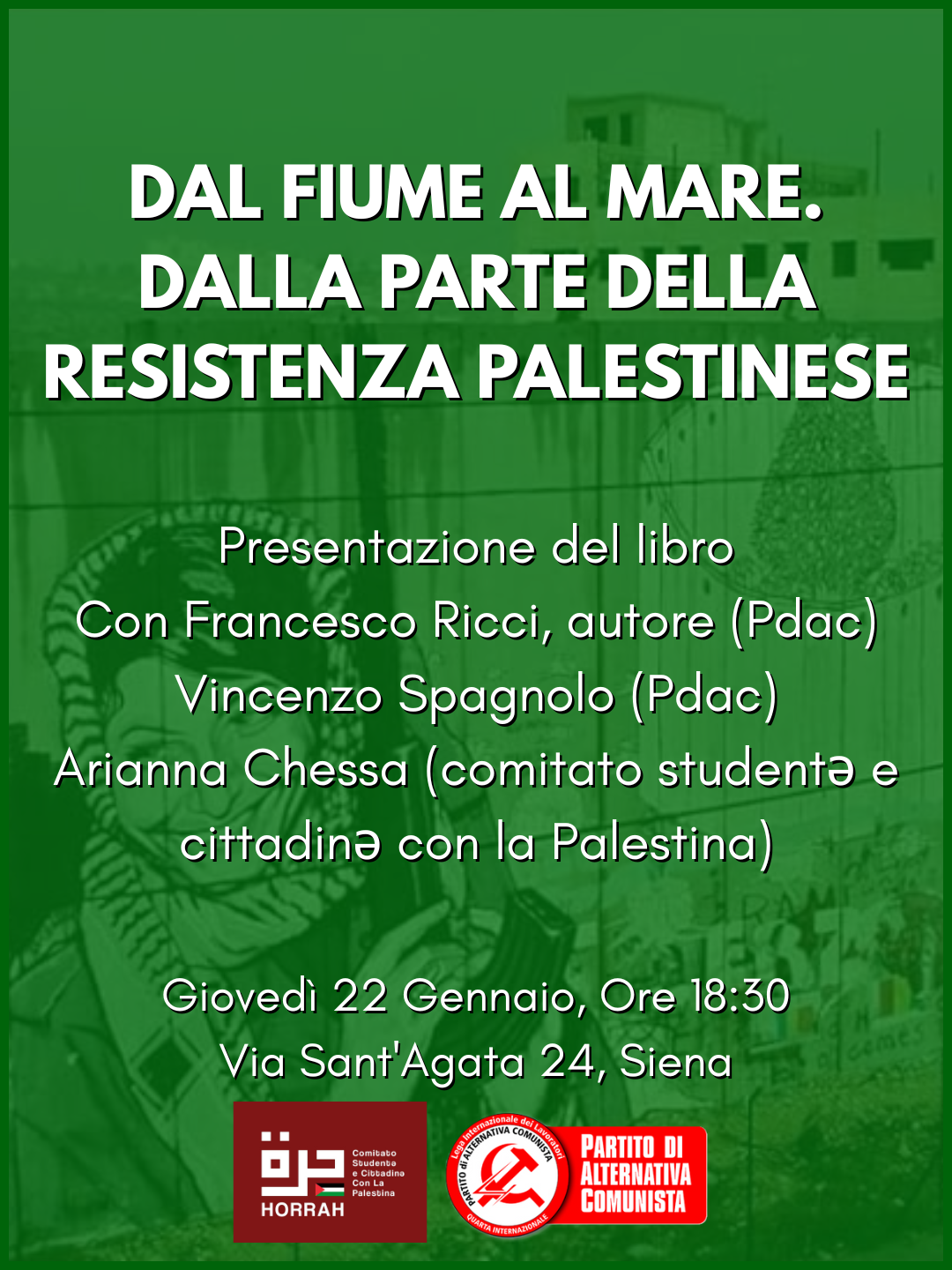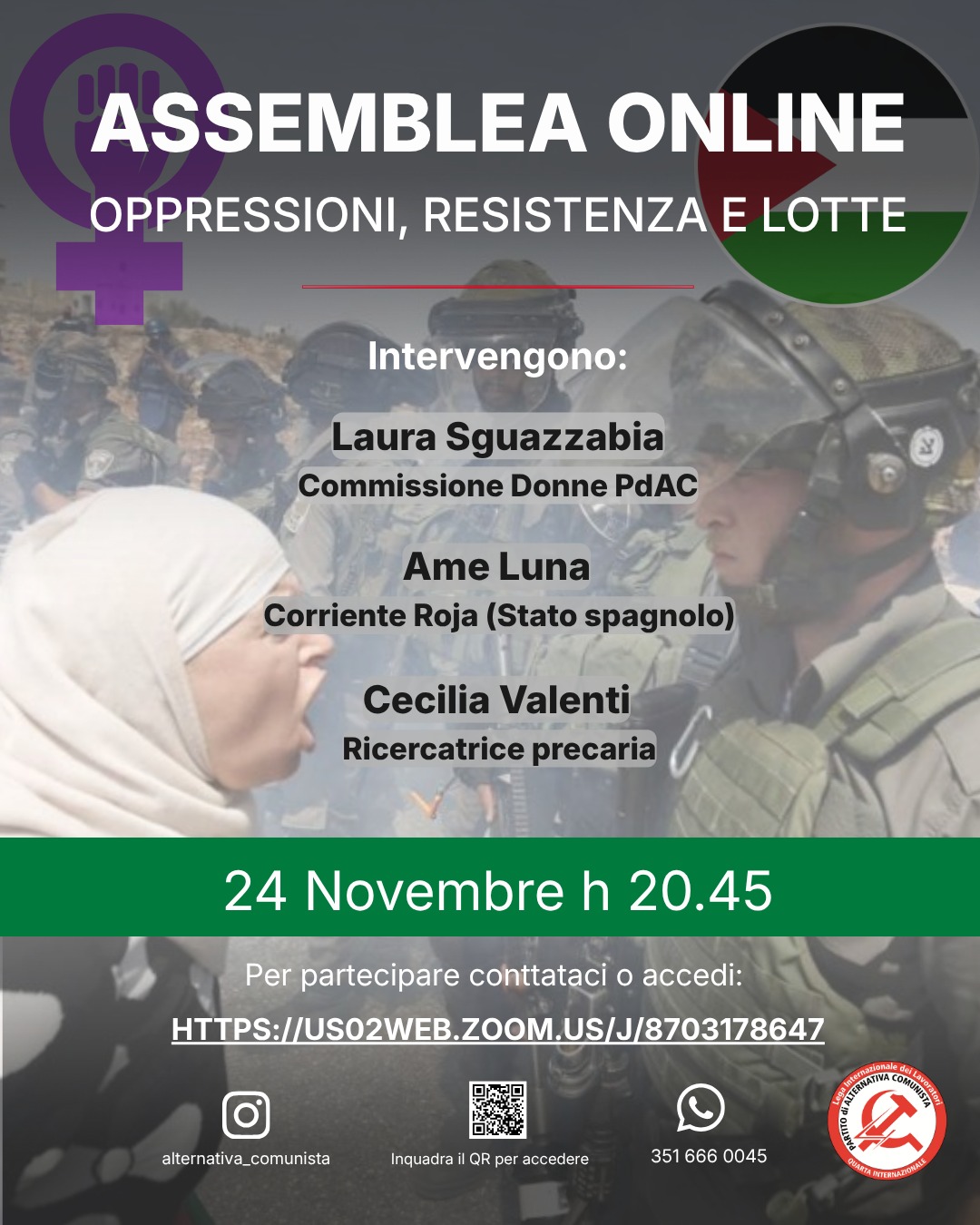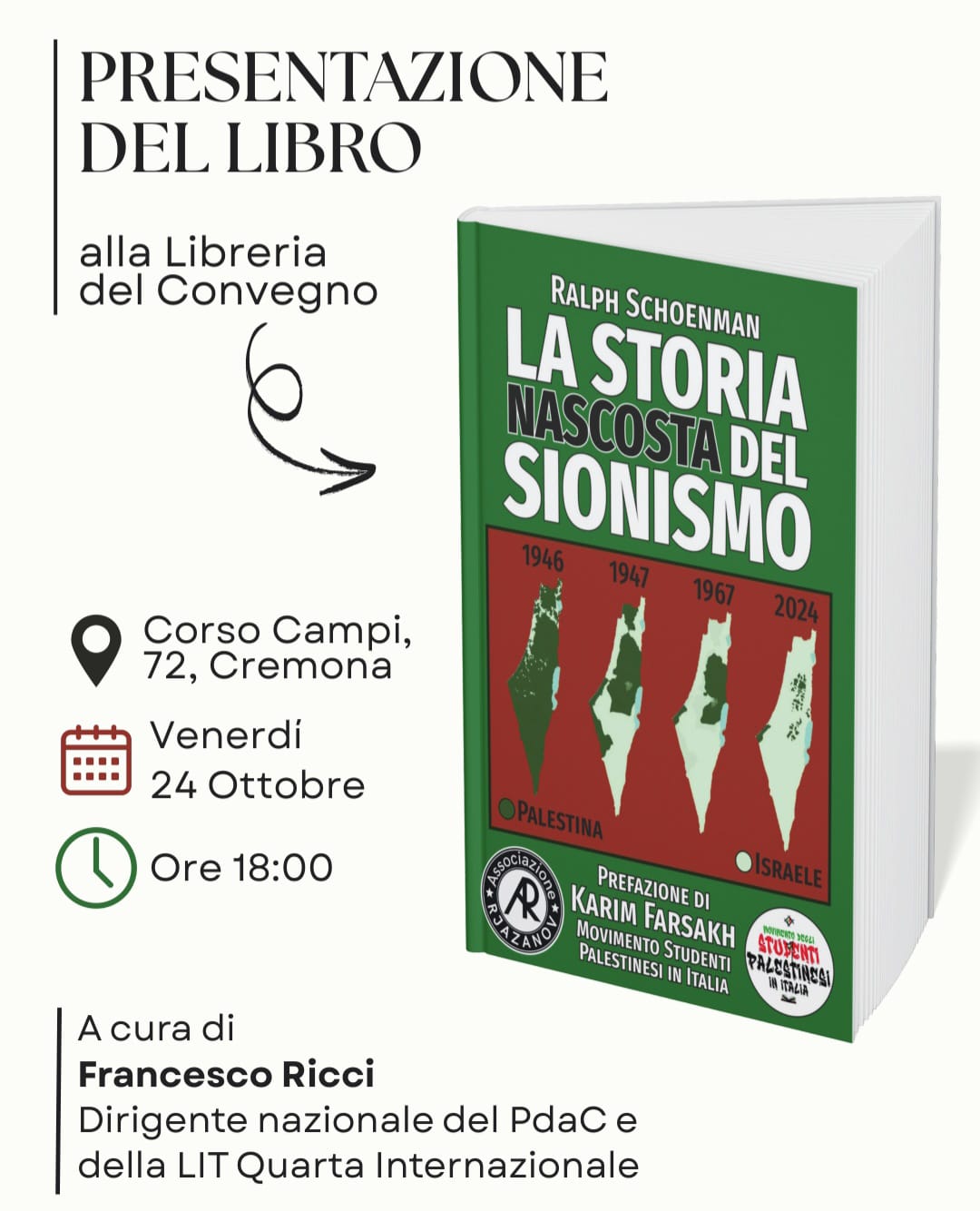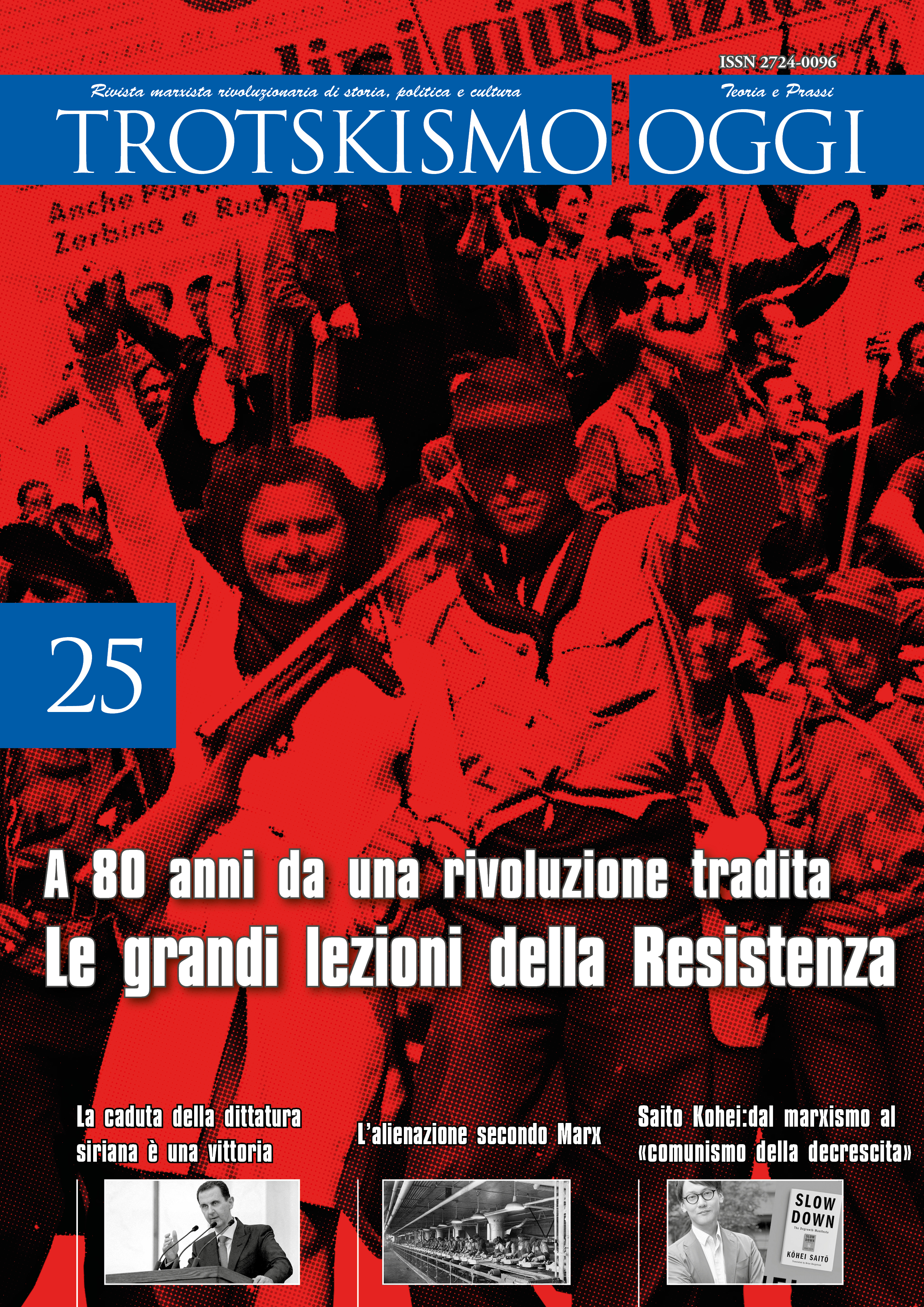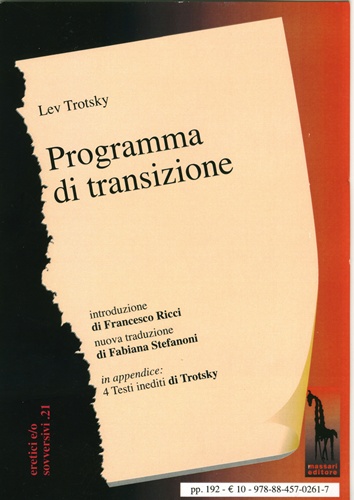A 110 anni dalla prima rivoluzione russa
1905
L’insostituibile ruolo del bolscevismo
di Ruggero Mantovani

“Lo sviluppo della coscienza di classe delle
masse sarà, come sempre, la base e il contenuto principale di tutto il nostro
lavoro… Attacco e non difesa: questa deve essere la parola d’ordine delle
masse; loro compito sarà l’implacabile annientamento del nemico”.
(Lenin “Gli Insegnamenti della Rivoluzione di
Mosca” agosto 1906).
La guerra imperialista della Russia contro il
Giappone (1) fu l’avvenimento più importante del 1904 e fu decisiva per lo
scoppio della rivoluzione del 1905, senza la quale sarebbe stata improbabile la
rivoluzione del 1917.
A registrare il clima di terrore e
repressione imposto dallo zarismo fu lo scrittore Lev Tolstoj, che il 16
gennaio 1902 denunciò con una missiva indirizzata a Nicola II quanto segue:
“[...] Un terzo della Russia si trova nello stato di emergenza, vale a dire
fuori della legge. L'esercito della polizia, ufficiale e segreta, continua ad
aumentare. Le prigioni, i luoghi di esilio e le colonie penali sono affollate
di prigionieri politici, tra i quali sono annoverati anche gli operai”.
La rivoluzione durò tutto l’intero anno
facendo emergere un protagonismo e una autonomia della classe operaia senza
precedenti, che cominciarono a scavare anche in quel mondo contadino
storicamente succube della borghesia e del paternalismo zarista.
All’inizio dell’insurrezione la classe
operaia, in particolare, pur avendo avanzato rivendicazioni democratiche ed
economiche - dalla fine dell'autocrazia all'assemblea costituente e alla
giornata lavorativa di otto ore – ben presto si rese conto che la borghesia era
legata mani e piedi all’autocrazia zarista.
Nel vivo di una straordinaria esperienza
rivoluzionaria, che cancellò ogni illusione di auto-riforma del sistema russo e
superando anche le concezioni mensceviche (riformiste che praticavano
l’alleanza con i liberali), si sancì un’alleanza tra il mondo operaio e il
bolscevismo, maturando la consapevolezza di essere l'avanguardia politica e
sociale per realizzare il socialismo nell’anello più debole dell’imperialismo
mondiale.
I principali avvenimenti della rivoluzione
La guerra acuì una crisi sociale senza
precedenti: sconfitte militari, disastro economico, disoccupazione, rincaro dei
beni di consumo che combinato con la riduzione della produzione agricola colpì
duramente tutte le città. In questo clima la reazione del proletariato russo
non si fece attendere.
Il 26 dicembre iniziò il grande sciopero dei
pozzi petroliferi di Bakue e il 16 gennaio, a Pietroburgo, entrarono in
sciopero le officine di Putilov, a seguito del licenziamento di quattro operai
iscritti all'Assemblea degli operai russi di fabbrica e d'officina,
estendendosi alla maggioranza dei siti produttivi di Pietroburgo che, anche in
questo caso, avanzarono rivendicazioni economiche e politiche: stabilire i
minimi salariali, ottenere la giornata lavorativa di otto ore, la separazione
tra Stato e Chiesa, la distribuzione della terra ai contadini, la fine della
guerra, la legalizzazione dei sindacati, il diritto di sciopero, la giornata
lavorativa di otto ore e le assicurazioni previdenziali gestite dallo Stato
Per tutta risposta lo Zar iniziò la
repressione: proclamò lo stato d'assedio nella capitale (affidato al granduca Vladimir
e al generale Vasil'cikov) e rafforzò il presidio militare nella città, dove
furono concentrati 22 mila soldati, reparti di cosacchi e di cavalleria.
La risposta operaia fu immediata: la mattina
di domenica 22 gennaio (il 9 gennaio secondo il vecchio calendario) circa 200
mila manifestanti, divisi in undici cortei provenienti da ciascuna delle
sezioni dell'Assemblea operaia, così come altri cortei, si misero in marcia
verso il Palazzo d'Inverno.
Malgrado le eroiche barricate operaie i
manifestanti furono respinti a fucilate provocando centinaia di feriti e di
morti.
Alla notizia della strage nella capitale
entrarono in sciopero gli operai di Mosca e della provincia, unitamente agli
operai delle fabbriche degli Urali, del bacino del Volga e ai metallurgici di
Tula, mentre da Saratov uno sciopero dei ferrovieri si estese alle stazioni
collegate.
Il 25 maggio 1905 la città di Ivanovo-Voznesensk,
situata nel distretto di Mosca (chiamata la “Manchester russa”), iniziò uno
sciopero con più di 40 mila aderenti.
Il giorno successivo gli operai di tutte le
fabbriche in sciopero elessero un Consiglio dei deputati operai rappresentando
le istanze comuni di tutta la massa degli scioperanti: così nacque il primo
soviet della storia.
L’insurrezione comincia a contagiare la marina, l’esercito e i contadini.
A Odessa, il 26 giugno, era stato dichiarato
lo sciopero generale e si verificò l’eroico ammutinamento dei marinai della corazzata
Potëmkin che la sera gettò le ancore al porto.
Il 28 giugno, quando la salma del marinaio Vakulenkuk
fu portata a terra, scoppiò la rivolta, culminata nella notte con l'incendio
dei magazzini portuali e la repressione dei cosacchi che provocò centinaia di
morti.
Dal 2 ottobre entrarono in sciopero anche i
tipografi di Mosca, seguiti dai fornai, dagli operai delle manifatture dei
tabacchi, dai tranvieri, ma ancora una volta i cosacchi spararono brutalmente
sugli scioperanti.
Malgrado la costante repressione zarista il
19 ottobre entrarono in agitazione anche i macchinisti e gli operai delle
officine della linea Mosca-Kazan' e il 20 ottobre l'Unione dichiarò lo sciopero
generale dei ferrovieri. In breve tutta la Russia si trovò paralizzata.
In questo costante clima insurrezionale nella
notte del 26 ottobre il primo Soviet dei deputati operai di Pietroburgo si
riunì in una sala dell'Istituto Tecnologico e il 27 ottobre, presente anche Lev
Trotsky appena giunto dalla Finlandia, furono ammessi i rappresentanti dei tre
partiti socialisti: social-rivoluzionari, menscevichi e bolscevichi.
Da comitato di sciopero, il soviet di
Pietroburgo si trasformò in breve in organo politico e rivoluzionario del
proletariato cittadino. Il suo esempio fu rapidamente imitato e sorsero in
tutta la Russia una cinquantina di soviet operai, oltre a qualche soviet di
soldati e di contadini. Il più importante, dopo quello di Pietroburgo, fu il
soviet operaio di Mosca.
L’8 novembre nella base navale di Kronštadt
dopo l’arresto di alcuni marinai, a seguito di comizi e rivendicazioni
economiche e politiche, scoppiò una rivolta armata che portò alla conquista
della città da parte degli insorti.
Il 23 novembre si ammutinarono anche i
marinai dell'incrociatore Ocakov, ormeggiato al porto di Sebastopoli, che
appoggiarono lo sciopero in corso nella città e arrestarono i loro ufficiali.
Altri marinai e la guarnigione di Sebastopoli
si unirono all'insurrezione e in città fu formato un soviet dei deputati,
marinai, operai e soldati, che reclamò l'Assemblea costituente, la giornata
lavorativa di otto ore, la soppressione della pena di morte e la liberazione
dei detenuti politici.
Ma gli ammutinati non si organizzarono
adeguatamente contro l'inevitabile reazione zarista, che il 27 novembre fece
sparare da truppe fedeli sulle navi ribelli e sulle caserme dei marinai: trenta
morti e settanta feriti il bilancio degli scontri.
Malgrado la repressione, il 9 novembre gli
operai delle officine metallurgiche decisero di propria iniziativa di ridurre
la loro giornata lavorativa a otto ore. Il soviet ratificò la decisione e l'11
novembre lanciò la lotta per la giornata di otto ore in tutte le fabbriche di
Pietroburgo.
Dopo tre giorni questo sciopero fu sospeso
per proclamarne un altro a favore dei seicento marinai protagonisti della
rivolta di Kronstadt che il governo minacciava di far giudicare dal tribunale
di guerra.
I padroni decisero la serrata delle fabbriche
e licenziarono 70 mila scioperanti.
L'ultima iniziativa di rilievo del soviet di
Pietroburgo, presa il 5 dicembre su impulso del suo presidente Trotsky,
riguardò il “manifesto finanziario” pubblicato il 15 dicembre, che chiamava
allo sciopero fiscale il proletariato russo, con l’intento di sottrarre ingenti
somme trattenute dalle banche zariste che da subito reagirono energicamente.
Dal 23 dicembre tutta la periferia di Mosca
era ricoperta di barricate.
In realtà, quella di Mosca non fu l'unica
rivolta armata nelle strade. A Novorossijsk il soviet operaio proclamò la
repubblica e resistette due settimane all'offensiva dell'esercito.
L'esempio fu imitato in Siberia, dove le
stazioni della ferrovia transiberiana diventarono un centro di resistenza, e a Krasnojarsk
e a Cita la “repubblica” tenne testa per un mese agli attacchi delle truppe
zariste.
Il quadro politico ed il ruolo dei bolscevichi.
E’ da notare che sia nel 1904 che nel 1914 i
menscevichi si rifiutarono di ricercare le causa della guerra nel conflitto imperialistico.
Nel 1904 la borghesia in Russia non era
ancora totalmente interna al potere zarista, a differenza del 1914 quando
l’autocrazia fece un passo in avanti verso una monarchia costituzionale e la
borghesia divenne sempre più legata mani e piedi all’imperialismo russo. Ne
derivò, nel 1904, un disfattismo dei menscevichi simile a quello dei liberali,
strumentale ad ottenere agevolazioni. Entrambi sapevano che se la Russia avesse
perso la guerra, l‘autocrazia sarebbe stata più debole e doveva per forza
maggiore fare concessioni.
Il disfattismo dei bolscevichi era invece
finalizzato a trasformare la guerra in lotta rivoluzionaria e i menscevichi,
per scongiurarlo, fecero blocco con i liberali che nel frattempo avevano
ripreso vigore, sottoscrivendo petizioni indirizzate allo Zar e insistendo che
non bisognava spaventare la borghesia. Riproponevano nei fatti la loro vecchia idea
di assegnare ai liberali la lotta politica e al proletariato le rivendicazioni
economiche.
Ma Lenin sapeva bene che in campo vi era una
grande forza, la classe operaia, l’unica che avrebbe spezzato, con i contadini,
le catene dell’autocrazia e del capitalismo.
Purtroppo, malgrado al II congresso del Posdr
(1903) la maggioranza fosse andata ai bolscevichi, in poco tempo, dopo
l’arresto di alcuni componenti del CC e la svolta opportunistica di Plechanov,
il CC e L’Iskra passarono nelle mani
dei menscevichi.
I bolscevichi non avevano più il controllo
del partito ed erano in clandestinità. Lenin a questo punto decise per la
scissione e si formò un’organizzazione centrale panrussa dei bolscevichi che
contrastò il CC menscevico.
I bolscevichi lanciarono tra le masse senza
guida politica la parola d’ordine dell’insurrezione e della formazione di un
governo rivoluzionario provvisorio. Nella metà del 1905 ebbe luogo il III
congresso, convocato dall’Ufficio dei comitati a Londra, a cui parteciparono
solo i bolscevichi: furono messe all’ordine del giorno l’insurrezione armata,
lo sciopero generale e la messa a punto di un programma per la rivoluzione
imminente.
Il movimento operaio e contadino si era
sviluppato di pari passo ai bolscevichi; l’esercito e la flotta cominciarono a
manifestare lo spirito di rivolta. L’autocrazia zarista cominciò a fare
concessioni e decise di convocare la Duma. (2)
A quel punto i menscevichi videro l’inizio
del parlamentarismo mentre i bolscevichi, sapendo che il tempo della
rivoluzione era maturo, rifiutarono qualsiasi partecipazione, tanto più che la
Duma poteva fornire privilegi solo alla borghesia.
Mentre nel 1871 Marx si affrettò con lo
scritto La guerra civile in Francia
ad esaltare l’azione dei comunardi, i menscevichi condannarono la rivoluzione.
Ma la rivoluzione del 1905 fu importante perché per la prima volta
l’insurrezione avvenne utilizzando le parole d’ordine dei bolscevichi,
preparando, in effetti, quella del 1917.
Sulle questioni di fondo nessuna contrapposizione tra Lenin e Trotsky.
Al di là di quanto sostenuto dai tristi
epigoni dello stalinismo, è bene sottolineare che sulle questioni essenziali
Trotsky non ebbe mai alcun disaccordo con Lenin: sull'indipendenza di classe
del proletariato e del partito rivoluzionario ruppe con i menscevichi di Martov;
nella rivoluzione del 1905 tutte le polemiche con Lenin sul centralismo si
sciolsero come neve al sole; nel 1917 confluì nel partito bolscevico con la sua
organizzazione composta da quattromila aderenti e al fianco di Lenin, che
riarmò il partito con le “Tesi di Aprile”, diresse la rivoluzione russa.
Non è un caso che tutta l'elaborazione di
Trotsky fu tesa a confermare l'insostituibile ruolo del partito d'avanguardia e
ad approfondire la dialettica leninista partito – masse.
Trotsky, prima di essere assassinato da un
sicario staliniano (il 20 agosto del 1940) scriveva il saggio Classe, partito, direzione in cui, nel
ribadire il ruolo insostituibile del partito d'avanguardia (espresso decenni
prima da Lenin nel Che Fare?)
riprendeva un concetto chiave che già nelle Lezioni
dell'Ottobre (1924) aveva espresso con queste parole: “Senza il partito, al
di fuori del partito, aggirando il partito, con un surrogato del partito la
rivoluzione proletaria non può vincere”.
Al contempo la teoria della rivoluzione permanente
elaborata da Trotsky e dal socialdemocratico Parvus, all'indomani della
rivoluzione del 1905, rappresenta senza dubbio un apporto essenziale al
marxismo conseguente. Trotsky giustamente contestò la vecchia formula leniniana
della “dittatura democratica degli operai e dei contadini”, che in effetti
risentiva di una visione maturata nella socialdemocrazia tedesca di Kautsky, ed
era ancora interna a una concezione "semi-tappista" della
rivoluzione, che avrebbe dovuto passare per una "tappa" democratica
(in una democrazia borghese) come premessa della dittatura del proletariato (al
contrario, per Trotsky, la dittatura del proletariato era la premessa
dell'assolvimento degli stessi compiti democratici di un'unica
"rivoluzione permanente".
Contemporaneamente, però, Lenin (su questo in
totale accordo con la posizione di Trotsky) denunciò senza esitazione il legame
tra la borghesia russa e l’imperialismo zarista e, a differenza dei menscevichi,
non attribuiva alcun potenziale ruolo egemone alla borghesia nella futura
rivoluzione.
Lenin ben sottolineava che le forze
capitaliste russe avevano riproposto ciò che era accaduto alla metà del
seicento in Inghilterra e nel 1789 dopo la rivoluzione francese e alla metà
dell’ottocento nel risorgimento italiano: si opponevano tenacemente alla
trascendenza popolare della rivoluzione per salvaguardare la sua egemonia
sociale.
Molto più correttamente Trotsky riteneva che
la “dittatura democratica rivoluzionaria” non era concepibile “senza la
dittatura del proletariato”, giungendo con l'opera “La nostra rivoluzione”, nel
paragrafo intitolato “Bilanci e prospettive” (1906), a rovesciare gli schemi
elaborati dalla socialdemocrazia, la quale riteneva che in Russia dovesse
realizzarsi in primo luogo una rivoluzione democratico-borghese.
Trotsky a questa impostazione oppose la sua
analisi, che ancor meglio riassumerà nel 1919 nella prefazione alla riedizione
di “Bilanci e prospettive”, in cui scrive: “inizialmente borghese per i suoi
compiti immediati la rivoluzione russa svilupperà rapidamente potenti
contraddizioni di classe e sfocerà in una vittoria solo trasferendo il potere
all'unica classe capace di porsi alla testa delle masse sfruttate, il
proletariato (...) una volta al potere, il proletariato non solo non vorrà ma
non potrà neanche limitarsi ad attuare il programma democratico-borghese. Esso
potrà portare la rivoluzione fino in fondo solo se la rivoluzione russa si
trasformerà in rivoluzione del proletariato europeo”.
D’altronde per il marxismo rivoluzionario il
programma comunista non ha mai rappresentato un postulato morale, un'ideologia
speculativa, un generico “manuale” sul capitalismo e sul socialismo: esso
riflette anzitutto il pensiero, le condizioni oggettive e gli obiettivi del
movimento operaio. Per dirla con Lenin “nel suo programma il proletariato deve
formulare la sua dichiarazione di guerra al capitalismo”.
Questa è stata fin dal suo nascere l'essenza
del programma comunista che, lungi dal celebrare il trionfo di una ricetta
salvifica, ha costituito il principale strumento di lotta politica del partito
rivoluzionario, concretizzandosi in un programma di rivendicazione transitorie:
nazionalizzazione delle risorse economiche e soppressione degli apparati
repressivi dello Stato borghese; controllo della produzione sociale da parte
dei soviet.
Come ribadirà Trotsky, nel continuare la
battaglia leninista contro il bonapartismo staliniano, citando Lenin, “nella
lotta per il potere, il proletariato non ha altra arma che l'organizzazione”.
Quali le cause del fallimento della rivoluzione del 1905 e quale insegnamento ne derivò?
Mentre i menscevichi ritenevano che il
fallimento della rivoluzione doveva addebitarsi esclusivamente alle
rivendicazioni “eccessive” che avevano prodotto una frattura con la borghesia;
i bolscevichi invece ritenevano che il fallimento era stato determinato: primo,
dal blocco borghese internazionale che fu il salvagente dello Zar e lo
strumento che rinsaldò i legami tra l’autocrazia e la borghesia russa; secondo,
dalla mancanza di una piena coscienza rivoluzionaria dei contadini e dall’incapacità
dei bolscevichi di trascinarli nei Soviet; terzo, dal tradimento della
borghesia, la quale comprendendo che il proletariato stava divenendo una forza
autonoma e che avrebbe spazzato via lo zarismo e i suoi interessi, abbandonò la
lotta e scese a compromessi con lo Zar.
Sul tema, Lenin, nell’agosto del 1906,
pubblica gli Insegnamenti della
Rivoluzione di Mosca in cui meglio approfondisce la dinamica
rivoluzionaria: “Il proletariato aveva avvertito prima dei suoi capi il
mutamento delle condizioni oggettive della lotta, la quale esigeva il passaggio
dallo sciopero all’insurrezione. Come sempre la pratica aveva preceduto la
teoria (...) gli operai chiedevano: 'e dopo?', esigevano azioni sempre più
energiche (...) si sarebbero dovute impugnare le armi con maggior decisione, si
sarebbe dovuto spiegare alle masse l’impossibilità di limitarsi ad uno sciopero
pacifico e la necessità di condurre una lotta armata intrepida e implacabile.
Questo è il primo insegnamento degli avvenimenti del dicembre 1905. Il secondo
riguarda il carattere della insurrezione (...) l’insurrezione è un’arte e la
regola principale di questa arte consiste nell’offensiva (...) noi non abbiamo
sufficientemente assimilato questa verità (...) è necessario un raggruppamento
basato sull’atteggiamento verso la insurrezione armata. Chi è contro di essa
deve essere gettato nel campo degli avversari, dei traditori, dei vili e dei
vigliacchi, perché si avvicina il giorno in cui la forza degli avvenimenti ci
costringeranno a distinguere nemici e amici in base a questo criterio (...) Il
terzo grande insegnamento che Mosca ci ha dato riguarda la tattica e
l’organizzazione delle forze per l’insurrezione (...) Mosca aveva creato una 'nuova
tattica delle barricate'. Questa tattica è la tattica della guerra partigiana
(...) che consiste nel creare squadre mobili molto piccole. La guerra
partigiana (...) si esercita in Russia insegnando alle masse l’impiego della
giusta tattica e quale tecnica militare sia utilmente impiegata nella
rivoluzione (...) ricordiamo che una grande lotta di massa si avvicina. Sarà
l’insurrezione armata.”
Quali le conseguenze di tutto ciò?
Quali furono le conseguenze degli avvenimenti
fin qui descritti? Prima tra tutte un raggruppamento delle forze di classe e il
passaggio della borghesia alla controrivoluzione.
La borghesia russa svolse un ruolo
determinante fino al 1905, come nel 1848 la borghesia tedesca utilizzò la
classe operaia per consolidare il suo potere.
Nel 1906 a Stoccolma si svolse il IV
congresso del Posdr (Partito Operaio Socialdemocratico Russo), che sotto la
spinta delle masse determinò una transitoria riunificazione tra menscevichi e
bolscevichi. Ma il contrasto era divenuto insanabile: i bolscevichi asserivano
che sarebbe arrivata un’altra rivoluzione, poiché i problemi che avevano
generato gli avvenimenti del 1905 non si erano risolti. I menscevichi, dal
canto loro, puntavano alla costituzione di una forza socialdemocratica simile a
quella europea, allontanandosi definitivamente dalla rivoluzione e intravedendo
la possibilità di un vero compromesso con la borghesia e il suo Partito
cadetto. (3)
Ma la vera riunificazione dei due gruppi
socialdemocratici non ci fu: vi erano ormai due partiti in uno.
Il ruolo di Lenin per salvare il partito bolscevico del settarismo
Lo Zar comunque sciolse la prima Duma per
tacitare il partito cadetto e le sue ambizioni. (4)
In questo quadro si svolse nel 1907 a Londra il
V congresso dei socialdemocratici russi (IV per i menscevichi) in cui entrarono
tre nuove organizzazioni: la socialdemocrazia lettone, quella polacca e il Bund
(5) che si dichiararono d’accordo sulle questioni tattiche con i menscevichi,
determinandone in varie votazioni la maggioranza.
Lenin ribadì il ruolo indipendente della
classe operaia e la necessità della rivoluzione, ottenendo in qualche votazione
una maggioranza instabile.
Nello stesso anno lo Zar sciolse la II Duma e
si pose la discussione all’interno del Posdr se parteciparvi o meno. E’ da
notare che tra i bolscevichi era maggioritaria la tendenza al boicottaggio,
poiché si riteneva che si sarebbe prodotto un movimento analogo al 1905.
Lenin, andato nel frattempo in minoranza,
ebbe la meglio solo per la sua autorevolezza: insisteva che bisognava stare
accanto agli operai sia nella Duma che nei sindacati, malgrado fossero
maggioritari i menscevichi, nelle cooperative e nei circoli, non bisognava
staccarsi dalle masse. Se avesse vinto la tendenza antileninista il bolscevismo
si sarebbe trasformato in una ridicola setta autocentrata.
Malgrado ciò, anche a seguito della
demoralizzazione del 1905, si produssero nel 1909 una serie di frazioni
settarie molto pericolose. L’otzovismo (6) fu una tendenza locale che
dichiarava il ritiro dei deputati dalla Duma, proponeva il carattere illegale
del partito e l’uscita dai sindacati e dai circoli; l’ultimatismo (7), una
variante più moderata dell’otzovismo, poneva l’ultimatum di svolta radicale;
per giungere alla versione più volgare con il deismo, che rappresentò una specie
di lettura mistico-religiosa del marxismo.
Anche nel menscevismo si produssero
disgregazioni: i liquidatori che auspicavano l’abbandono del partito
rivoluzionario; i partitisti (Plechanov) che ritenevano la necessità di
mantenere i connotati originari.
L’ultimo tentativo di mantenere l’unità tra
bolscevichi e menscevichi si ebbe a Parigi nel 1910 durante un Comitato
Centrale, dove la corrente dei bolscevichi conciliatori, ottenendo la
maggioranza e mettendo in minoranza Lenin, fece l’errore di non saper riconoscere
che già nel 1909-1910 vi erano le condizioni per la rottura definitiva con i
menscevichi.
La rottura definitiva si ebbe a Praga nel
1912, quando i bolscevichi ebbero la maggioranza, garantiti anche da una nuova
classe operaia che si era formata tra il 1907 al 1911 durante il periodo della
reazione e nelle nuove mobilitazioni: rialzarono la bandiera del bolscevismo e
fondarono La Pravda. (8)
Verso la fine del 1912 dopo gli anni duri
della reazione dunque due forze si contrapponevano: da una parte i bolscevichi
con il nuovo partito, dall’altra i menscevichi raggruppati sotto la bandiera
delle rivendicazioni parziali e della monarchia costituzionale.
La classe operaia apre la porta alla rivoluzione del 1917
Nel frattempo durante il 1912 e il 1913 crescevano,
di nuovo, le mobilitazioni sociali.
Nel 1913 e soprattutto nel 1914 il conflitto
sociale si riacutizzò: si videro le prime barricate e si ricreò una situazione con
analogie con quella del 1905 ma con una classe operaia e contadina più avanzata
e un partito più forte.
Ma la guerra portò alla distruzione del
partito e della stessa Seconda Internazionale. Lenin esule lanciava la parola
d’ordine della trasformazione della guerra imperialista in guerra civile,
tentando di attrarre l’estrema sinistra della II Internazionale, ma tutte le
porte si chiusero inesorabilmente.
Quando scoppiò la guerra la maggioranza delle
tendenze socialiste russe erano socialscioviniste tranne il bolscevismo, che
continuò ridotto al lumicino a costituire una piccola tendenza di sinistra nel
movimento zimmerwaldiano.
Una situazione che condusse il bolscevismo,
ancora nel febbraio del 1917, ad essere una forza del tutto minoritaria nella
sinistra. Ma nel momento in cui le forze mensceviche fecero di nuovo l’accordo
con la borghesia imperialista, il bolscevismo, "riarmato" da Lenin e
Trotsky, seppe realizzare la rivoluzione d'Ottobre, filo conduttore della
storia del marxismo rivoluzionario fino ai giorni nostri.
Note
1) Il 1º marzo 1903 il generale Kuropatkin annotava sul suo diario che Nicola II aveva "progetti grandiosi: impadronirsi della Manciuria e annettersi la Corea. Egli sogna anche di porre il Tibet sotto il suo dominio. Vuole prendere la Persia e impadronirsi non solo del Bosforo ma anche dei Dardanelli", mirante all'annessione di quei territori, in possesso della Cina e oggetto delle mire imperialistiche del Giappone.
2) Assemblea rappresentativa istituita da Nicola II nel 1905. Avrebbe dovuto essere un corpo consultivo, con il compito della discussione preliminare e dell’elaborazione delle leggi: i risultati sarebbero stati poi sottoposti al Consiglio di Stato, mentre lo Zar manteneva il diritto assoluto di veto. La prima Duma fu convocata nel maggio 1906. Era composta di 486 membri, e venne sciolta per ordine dello Zar il 21 luglio dello stesso anno. Nel marzo 1907 si riunì la seconda Duma, sciolta anch’essa il 16 giugno. La terza fu convocata per il novembre successivo, e fu l’unica che riuscì a completare il proprio mandato di cinque anni. Nella quarta Duma, che si riunì alla fine del 1912, le elezioni avevano garantito la maggioranza ai conservatori, dei quali gli Ottobristi costituivano il gruppo di maggiore importanza.
3) Il “partito cadetto” (che prese il nome dalle iniziali K. D. del suo nome: costituzionale-democratico) fu il maggior partito della borghesia monarchico-liberale in Russia. Venne costituito nel 1905. Cercò di conquistare adesioni anche tra le masse contadine e di trasformare il regime zarista in un regime monarchico costituzionale. Si definì perciò anche come partito “della libertà del popolo”. Trasformatosi nel rappresentante della borghesia imperialista durante la Prima guerra mondiale, fu spazzato via dalla Rivoluzione d’Ottobre.
4) Lo Zar sciolse la II Duma (3 giugno 1907) ed emanò una nuova legge elettorale che assicurava, nella nuova Duma, la maggioranza assoluta alle forze dell’estrema destra politica e del blocco agrario-industriale. Il periodo che seguì il 3 giugno fu quello della brutale e sanguinosa reazione di Stolypin, capo del regime poliziesco.
5) Il Bund (Unione generale operaia ebraica in Lituania, Polonia e Russia) fu fondata nel 1897. Sosteneva il separatismo e il nazionalismo nel movimento operaio.
6) Da “Otozvat”= “ritirare”, sotto la direzione di Alksinskij, Bogdanov, e Lunakarskij si costituirono in gruppo nel 1908 e pretesero il “ritiro” dei deputati socialdemocratici dalla III Duma (1907-1912) nonché la rinuncia a svolgere in essa, nei sindacati, nelle cooperative, e negli altri organismi di massa, legali e semilegali, qualsiasi azione politica.
7) Gli “ultimatisti” si distinguevano dagli “otzovisti” solo per la forma: esigevano che il partito ponesse un ultimatum per farsi espellere dalla Duma.
8) Pravda (la Verità): quotidiano bolscevico sorto per iniziativa degli operai di Pietroburgo. Il primo numero uscì il 22 aprile 1912 (riprendendo il titolo di una testata precedentemente edita da Trotsky). Il 5 luglio venne soppresso dal governo ma in seguito riapparve, divenendo l’organo di stampa ufficiale dei bolscevichi.